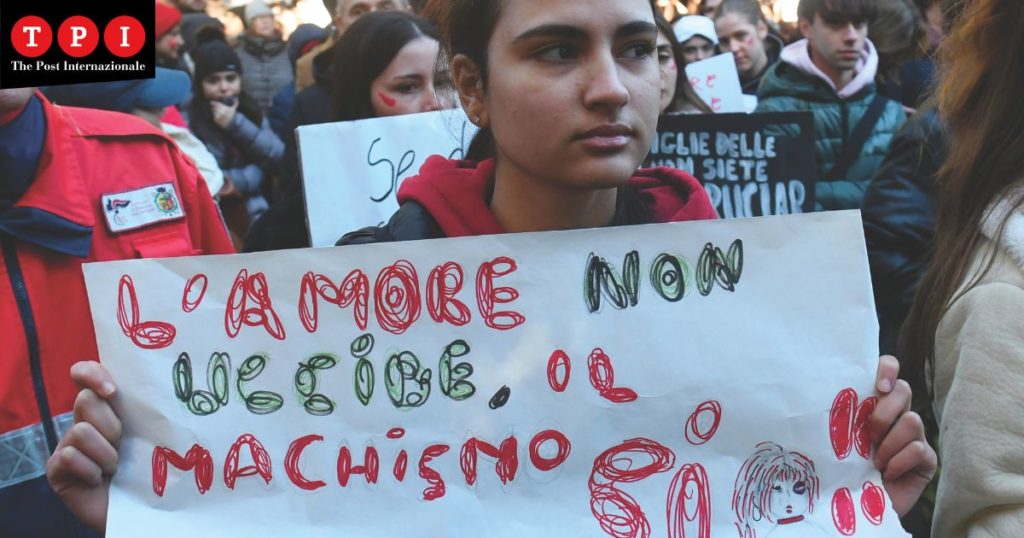Donald Trump vorrebbe passare alla storia come un grande artefice di pace, meglio se insignito del premio Nobel. Sull’Ucraina gli si può, al limite, accordare il beneficio del dubbio: forse l’accusa, formulata da molti commentatori, di cospirare con Putin ai danni di Kiev, per poi accordarsi con lui sulla spartizione delle risorse minerarie dell’Artico e su molto altro, è ingiusta. Né possiamo affermare con certezza che ad Anchorage si sia lasciato manipolare dal più furbo interlocutore e non abbia ottenuto alcuna attenuazione delle pretese russe: la asserita rinuncia a completare la conquista delle province di Zaporizhzhya e Khersòn (già occupate per tre quarti) e la disponibilità a tollerare la presenza di peacekeepers non-Nato in Ucraina e di «forze di rassicurazione» occidentali nelle vicinanze dei suoi confini, se confermate quando si aprirà il tavolo negoziale, sarebbero due importanti tasselli di un accordo di pace, certo ingiusto, ma realistico.
Possiamo anche prendere per buona la sua pena per l’inutile emorragia di vite umane lungo il fronte (quasi un migliaio di militari al giorno) e per i civili ucraini uccisi dai missili e droni russi. Ma solo a patto di riconoscergli una forte dose di – sia pur inconsapevole – razzismo: le vittime dei bombardamenti fanno pena se sono europei bianchi.
Un progetto diabolico
La cosa è ben diversa se sono arabi di Gaza (e di Cisgiordania). Qui qualsiasi eccesso o crimine israeliano contro i civili palestinesi è giustificato: necessità di eliminare la minaccia terroristica, danni collaterali, scudi umani usati da Hamas, non importa quale sia il pretesto scelto da Netanyahu e dai portavoce della Idf (sottinteso: i gazawi meritano la punizione collettiva perché hanno votato per Hamas, tollerato il suo regime autoritario, non condannato l’eccidio del 7 ottobre).
Anzi, Donald incita l’amico Bibi a fare presto, a liberare Gaza City dal suo milione di abitanti entro due settimane, anche se questo comporta evidentemente le maniere forti per sloggiare quelli che non se la sentono di partire, o sono troppo deboli o malati, o non sanno dove andare. L’importante è sgombrare il terreno da tutti quei corpi ancora vivi e dalle rovine per cominciare senza indugi la realizzazione del meraviglioso progetto di Riviera del Medio Oriente. Progetto che inizialmente era sembrato solo uno scherzo di pessimo gusto, e ora si rivela essere un mostruoso affare immobiliare che si amalgama con il piano di pulizia etnica apertamente perseguito dai potenti ministri di estrema destra Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, e avallato dallo stesso Netanyahu.
Che questo diabolico piano sia qualcosa di più che una effimera fantasia del vulcanico Trump (ispirato dal “primo genero”, Jared Kushner) è dimostrato dalla complicità di Tony Blair, l’ex primo ministro britannico laburista che poi dal 2007 al 2015 è stato coordinatore e inviato speciale del “Quartetto” per il Medio Oriente, senza che si conosca il benché minimo contributo da lui dato alla soluzione del problema palestinese. Blair deve essersi convinto che la sua versione del piano è moralmente ineccepibile e che lui non rischia di essere incriminato dal Procuratore presso il Tribunale Penale dell’Aja per concorso in pulizia etnica solo perché non prevede la deportazione della popolazione palestinese dalla Striscia. I gazawi avranno infatti la scelta fra emigrare volontariamente, incassando un premio di cinquemila dollari, e lasciarsi rinchiudere in un gigantesco lager a Rafah, sempre con la prospettiva di una successiva emigrazione.
Sisifo in Medio Oriente
La dirigenza dell’esercito israeliano (Idf), pur esprimendo le proprie riserve sulla fattibilità della ripulitura etnica del Nord della Striscia, non ha rifiutato di obbedire. Ma ha fatto sapere che ci vorranno circa due anni. Se nessuno riuscirà a convincere il presidente americano che questa operazione non si può fare in due settimane, e neanche in due mesi, e che comporterà altre decine di migliaia di morti e un grave danno di immagine internazionalmente, Israele andrà incontro non solo a solenni funerali per tutti gli ostaggi rimasti, ma a una incessante, sanguinosa e inconcludente fatica di Sisifo: evacuazioni forzate, assedii, rastrellamenti, rappresaglie per attentati. Molti palestinesi moriranno, altri si lasceranno indurre dai lauti incentivi e dalla fame ad emigrare, ma moltissimi resteranno. Fra questi Hamas continuerà a reclutare senza difficoltà giovani disposti a correre i pericoli di una aspra guerriglia, non avendo niente da perdere.
Vorrà l’America incoraggiare il governo di Gerusalemme a cacciarsi in questo suo Vietnam? E vorrà impegnarsi a finanziarlo e rifornirlo di armi, sapendo come è andata in Afghanistan? Le analogie sono molte. Gli Stati Uniti, come ora Israele contro Hamas a Gaza, avevano sconfitto i talebani ma non erano stati in grado di controllare e pacificare il Paese. Le loro forze di occupazione erano diventate bersagli di azioni terroristiche; i miliziani, animati da una fede fondamentalista, si mostravano disposti a resistere per decenni. L’inevitabile esito, come nel 1975 nel Sud-Vietnam, fu il rovinoso ritiro delle forze americane (e occidentali). A lungo rinviato da Obama, era stato negoziato dallo stesso Trump, anche se lui ha poi accusato di ignominia Joe Biden, che lo ha soltanto eseguito.
I rischi per l’Occidente
Che Trump abbia la capacità di elaborare le lezioni della storia è improbabile. Ma i generali americani avranno studiato l’errore loro o di quei loro colleghi che avevano propugnato la strategia del «surge», e qualcuno di loro dovrà avere il coraggio di dirgli che non è nell’interesse di Israele scivolare lungo la stessa china. E anche fra i politici a lui vicini (Vance? Rubio?) qualcuno dovrebbe fargli capire che non è nell’interesse degli stessi Stati Uniti assecondare quella avventura militare e coltivare l’utopia/distopia della Riviera di Gaza.
Dalla eterogenea coalizione che si è raccolta a Tientsin intorno al trio Xi-Putin-Kim viene un chiaro messaggio: l’insofferenza per l’arroganza dell’America, per l’intero Occidente con il suo atteggiamento di superiorità morale, per i «double standards» a beneficio di Israele, offusca la riprovazione per la guerra di aggressione russa, unifica il Global South e lo getta fra le braccia del rinato binomio antidemocratico russo-cinese.
Questo rovesciamento dell’ordine internazionale deve preoccupare noi europei quanto l’America. Ma anche la pulizia etnica di Gaza, pur parziale, non rimarrà senza conseguenze per noi. Dopo la Nakbah (catastrofe) del 1948-49, molti giovani cresciuti nei campi profughi palestinesi si arruolarono nei movimenti di liberazione e nelle relative formazioni terroristiche. Il riconoscimento, da parte della maggioranza dei paesi anche occidentali, della rappresentatività dell’Olp e del diritto del popolo palestinese ad avere un suo Stato spinse Arafat a scegliere una strategia politica, non-violenta. I nuovi campi profughi che probabilmente finiranno per sorgere nei deserti dell’Egitto e della Giordania saranno ideali terreni di coltura per una nuova generazione di terroristi.